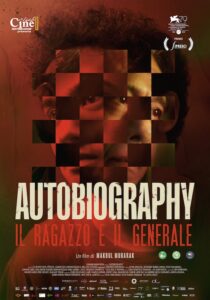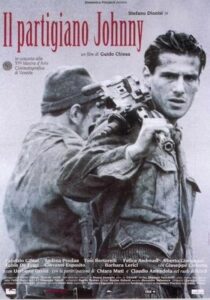Giappone 2018 – 1h 20′
 VENEZIA – Con Nobi – Fires on the plane (2014), il regista giapponese Shin’ya Tsukamoto scaraventava lo spettatore dentro l’orrore puro della guerra e lo costringeva ad assistere al semplice e deflagrante annientamento dell’umanità del suo protagonista. A quattro anni di distanza da quel bellissimo e sentito remake (del film di Kon Ichikawa del 1959), il regista di Tokyo torna nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia con Zan – Killing, un film purtroppo ignorato nel palmaresse del Festival, ma comunque tra i più belli e necessari tra quelli presentati al Lido quest’anno.
VENEZIA – Con Nobi – Fires on the plane (2014), il regista giapponese Shin’ya Tsukamoto scaraventava lo spettatore dentro l’orrore puro della guerra e lo costringeva ad assistere al semplice e deflagrante annientamento dell’umanità del suo protagonista. A quattro anni di distanza da quel bellissimo e sentito remake (del film di Kon Ichikawa del 1959), il regista di Tokyo torna nel concorso ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia con Zan – Killing, un film purtroppo ignorato nel palmaresse del Festival, ma comunque tra i più belli e necessari tra quelli presentati al Lido quest’anno.

La storia narrata è quella del un ronin, samurai senza padrone, Tsukuki che vive ospitato in un villaggio di campagna in cambio di protezione. È il Giappone di metà Ottocento e l’eco della guerra civile non tarda a raggiungere e infrangere il placido incedere delle giornate del giovane guerriero. Tsukuki si allena e gioca alla guerra con l’amico Ichisuke e corteggia da lontano sua sorella Yu; pare bramare l’azione della battaglia finché il suo equilibrio e il cristallino senso dell’onore non vengono sconvolti dall’arrivo di Sawamura (ne veste i panni lo stesso Tsukamoto), che lo invita a seguirlo in città dove il conflitto sta – finalmente – divampando.
 La guerra ancora dunque, e le sue conseguenze sull’uomo e il suo spirito (e sulla storia, ovviamente). Ma non sarebbe corretto considerare Zan solo come una branchia del discorso già intrapreso in Nobi: Zan è, evidentemente, un film piccolo per metraggio e budget produttivo ma enorme proprio nello svelarsi dei suoi significati e, come ogni altro progetto di Tsukamoto, è il nuovo tassello di una filmografia e di un percorso artistico in continua e vibrante evoluzione in cui le antitesi chiariscono il proprio senso e l’animo umano viene indagato, squartato e esplorato come fosse materia. Tra la vita e la morte (e la malattia, in A snake of June), e attraverso e oltre la distanza tra l’anima e il corpo, il regista giapponese si è insinuato col ferro di una pistola (Bullet Ballet), dei bisturi (Vital) e ora con quello che forgia una spada. L’arma è quella che il giovane protagonista non vede l’ora di utilizzare, almeno finché non scopre che la concretezza di quella perfetta coreografia, e la ritualità dei gesti a cui si è allenato per tanto tempo, coincide col sangue delle persone che dovrà uccidere.
La guerra ancora dunque, e le sue conseguenze sull’uomo e il suo spirito (e sulla storia, ovviamente). Ma non sarebbe corretto considerare Zan solo come una branchia del discorso già intrapreso in Nobi: Zan è, evidentemente, un film piccolo per metraggio e budget produttivo ma enorme proprio nello svelarsi dei suoi significati e, come ogni altro progetto di Tsukamoto, è il nuovo tassello di una filmografia e di un percorso artistico in continua e vibrante evoluzione in cui le antitesi chiariscono il proprio senso e l’animo umano viene indagato, squartato e esplorato come fosse materia. Tra la vita e la morte (e la malattia, in A snake of June), e attraverso e oltre la distanza tra l’anima e il corpo, il regista giapponese si è insinuato col ferro di una pistola (Bullet Ballet), dei bisturi (Vital) e ora con quello che forgia una spada. L’arma è quella che il giovane protagonista non vede l’ora di utilizzare, almeno finché non scopre che la concretezza di quella perfetta coreografia, e la ritualità dei gesti a cui si è allenato per tanto tempo, coincide col sangue delle persone che dovrà uccidere.
 La Natura si allontana dall’uomo e si fa qui incubo e spettro di chi si riconosce desideroso e al tempo stesso terrorizzato dalla possibilità di uccidere: la disumanizzazione passa attraverso il corpo, la carne, che tenta, invece, disperatamente di ritrovare la propria essenza vitale. Tsukuki tenta di ritrovarsi nell’amore per Yu in una liturgia di corpi che lo scoprirà ormai definitivamente mutilato. È proprio Yu lo specchio di questo abisso; la sua apparente innocenza e ingenuità – nel chiedere goffamente all’amato di non partire per la guerra, e di non farsi ammazzare – si traducono nella totale consapevolezza della tragedia incombente, e dell’irreversibilità del suo epilogo. La brutalità del campo di battaglia può restare visivamente fuoricampo: oltre la dimensione della scena, scrutando e attraversando mente, sguardo, impulsi e fibre vitali, la guerra nel frattempo si consuma e annienta qualsiasi cosa.
La Natura si allontana dall’uomo e si fa qui incubo e spettro di chi si riconosce desideroso e al tempo stesso terrorizzato dalla possibilità di uccidere: la disumanizzazione passa attraverso il corpo, la carne, che tenta, invece, disperatamente di ritrovare la propria essenza vitale. Tsukuki tenta di ritrovarsi nell’amore per Yu in una liturgia di corpi che lo scoprirà ormai definitivamente mutilato. È proprio Yu lo specchio di questo abisso; la sua apparente innocenza e ingenuità – nel chiedere goffamente all’amato di non partire per la guerra, e di non farsi ammazzare – si traducono nella totale consapevolezza della tragedia incombente, e dell’irreversibilità del suo epilogo. La brutalità del campo di battaglia può restare visivamente fuoricampo: oltre la dimensione della scena, scrutando e attraversando mente, sguardo, impulsi e fibre vitali, la guerra nel frattempo si consuma e annienta qualsiasi cosa.
Valentina Torresan – MCmagazine 47