|
La sezione
CINEASTI DEL PRESENTE
del Festival si propone come uno
“spazio di ricerca e di scoperta”, presentando opere di
registi più o meno emergenti, accomunati dalla tensione verso
un linguaggio innovativo e operanti anche in ambiti diversi
dal cinema: dalla videoarte al documentario.
Due artisti, più noti forse nell'ambiente dell'arte
contemporanea, hanno presentato le loro opere: Douglas Gordon
con I had nowhere to go
e Yuri Ancarani con
The Challenge. |
|
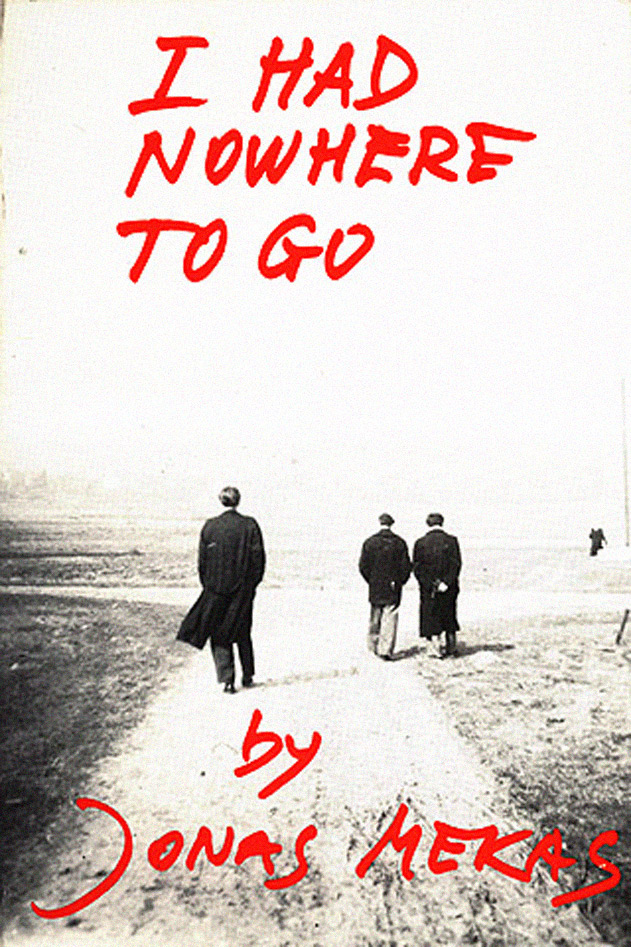 Douglas Gordon, artista poliedrico, di fama internazionale
ha diretto un film incentrato sulla figura di Jonas Mekas,
regista di culto dell' ”avanguardia americana”, la cui voce,
su uno schermo prevalentemente nero, racconta la sua fuga
dalla Lituania alla fine della Seconda Guerra Mondiale e i
cinque lunghi anni trascorsi da profugo in una Germania in
fiamme, da Wiesbaden a Kassel, prima di approdare a Brooklyn.
Douglas Gordon, artista poliedrico, di fama internazionale
ha diretto un film incentrato sulla figura di Jonas Mekas,
regista di culto dell' ”avanguardia americana”, la cui voce,
su uno schermo prevalentemente nero, racconta la sua fuga
dalla Lituania alla fine della Seconda Guerra Mondiale e i
cinque lunghi anni trascorsi da profugo in una Germania in
fiamme, da Wiesbaden a Kassel, prima di approdare a Brooklyn.
Una riflessione sul tempo, o meglio sulla percezione
soggettiva di esso, caratterizza molte delle opere di questo
artista, in particolare quelle in cui egli agisce sui
fotogrammi di celebri film, la più famosa 24 Hours Psyco.
Il tempo, questa volta della memoria, è il filo conduttore
anche del film presentato a Locarno, un tempo quindi non
lineare, ma che si sposta dal presente al passato e viceversa,
seguendo il percorso del pensiero di chi racconta le sue
storie. Storie soprattutto di guerra, di campi profughi, di
bombardamenti, di fame, di cui l'immaginario cinematografico
(e non solo) è saturo. Di qui la scelta di Gordon di non
accompagnare le parole, già di per sé fortemente evocative, di
Mekas con delle immagini, ma di squarciare ogni tanto lo
schermo nero con visioni, che rimandano, anche se non in
sincrono, a ciò che viene raccontato: patate e rape (l'unico
pasto dei profughi), uno scimpanzé tristissimo (l'unico
animale dello zoo sopravvissuto al bombardamento di Amburgo) o
con suoni che riproducono l'orrore dei bombardamenti.

Questo rifiuto dell'immagine si
ritrova anche in altri artisti contemporanei, che lavorano sui
suoni, gli odori, ecc. In particolare l'opera di Gordon si
avvicina in questo a una straordinaria installazione
dell'artista canadese Janet Cardiff, presentata a Documenta
13 a Kassel, dove l'orrore e l'angoscia della guerra
vengono proposti ai visitatori unicamente attraverso dei suoni
e delle voci, che rompono il silenzio di un boschetto del
Federicianum.
Altrettanto suggestiva e coinvolgente è apparsa l'opera di
Gordon, in cui la bellissima voce del novantaquattrenne Mekas,
qui in veste non di artista famoso, ma di profugo, è riuscita
ad inchiodare fino alla fine di fronte ad uno schermo nero per
100 minuti gli spettatori, trasformati testimoni silenziosi di
un dramma universale (pare che le fughe dalla sala durante la
proiezione siano avvenute soltanto alla proiezione per la
stampa!!!).
“La gioventù di questo cineasta fondamentale, che era
appena riuscito a fuggire al peggior incubo del secolo,
rappresenta la storia di un emigrato che non potrà mai
ritornare a casa e la cui solitudine nel Nuovo Mondo è
emblematica di ciò che Freud aveva definito “l'ordinaria
infelicità” nelle metropoli.” (Douglas Gordon) |
|
 Se
il film di Gordon è sicuramente una delle cose più
interessanti viste al Festival, non altrettanto riuscita è
apparsa l'opera di Yuri Ancarani
The Challenge. Se
il film di Gordon è sicuramente una delle cose più
interessanti viste al Festival, non altrettanto riuscita è
apparsa l'opera di Yuri Ancarani
The Challenge.
Artista più giovane e meno noto di Gordon, ma molto
promettente nell'ambito della videoarte, l'italiano Ancarani è
conosciuto soprattutto per due cortometraggi: Piattaforma,
prodotto da Maurizio Cattelan e presentato a Venezia nel 2011
e San Siro del 2014, entrambi caratterizzati da una
singolare modalità di esplorazione dello spazio (l'interno di
una camera iperbarica in una piattaforma per l'estrazione del
gas nel primo e lo stadio di San Siro vuoto la seconda)
condotta in soggettiva di uno sguardo fantasma, che conferisce
a questi spazi vuoti una connotazione straniante.

Lo spazio è protagonista anche
del film (il suo primo lungometraggio) presentato a Locarno:
lo spazio del deserto del Qatar. Il punto di vista qui è però
esterno e solo nelle ultime bellissime sequenze sarà lo
sguardo libero di un falcone a guidare la visione dall'alto
delle distese del deserto.
Il resto del film appare più come un documentario ben
confezionato, che offre immagini molto suggestive nel
mostrarci un mondo sicuramente per noi occidentali
sorprendente, in cui emiri ricchissimi scorrazzano con
lussuosi fuoristrada e Harley Davidson per il deserto (mentre
soltanto i turisti si muovono sui cammelli) o portano i loro
falconi su aerei privati, accompagnati da leopardi, ronfanti
come gattoni, come animali di compagnia.


Il film racconta un raduno di
allevatori di falchi da caccia per un torneo nel deserto. Se
lo scopo di Ancarani era quello di far emergere la singolare
convivenza all'interno del nuovo mondo arabo di elementi della
modernità con lo spirito della tradizione, che pur sopravvive
(la caccia col falcone), esso è stato raggiunto, ma senza
purtroppo comunicare niente di più di un messaggio scontato, a
cui il linguaggio non aggiunge alcun significato ulteriore. |
|
Cristina Menegolli |
|
|
|
>>
Nel panorama delle eccezioni sarebbe un torto non segnalare la
visione di un film la cui sinossi non è stata accolta dai più
come particolarmente invitante: “Le bestie arrivano di
notte. Sentono. Resistono. Prima dell’alba, un giovane le
conduce a morire mentre il suo cane scopre un mondo spaventoso
che sembra non avere fine”. L’autrice è la giovane
filosofa francese Maud Alpi, e
Gorge, coeur, ventre (Still
Life il titolo inglese ma che letteralmente si traduce
Gola, cuore, ventre) è la suo opera prima, inserita
all’interno della sezione competitiva Cineasti del presente.

Decidere di costruire un film all’interno
di un mattatoio, o meglio decidere di ergere il mattatoio come
luogo cardine di una riflessione che va ben oltre la supposta
e programmatica crudeltà assassina per il cui scopo è stato
progettato lo stesso, richiede una consapevolezza di
osservazione in grado di spingersi oltre la documentazione
dello svolgersi di un rituale lavorativo senza il quale i menu
delle nostre tavole sarebbe radicalmente orientato verso altri
sapori.


Perciò, la necessità della quale si è
sentita investita la regista - e di cui ha brevemente
accennato nella breve introduzione prima della proiezione in
sala - di raccontare questa esperienza che di fatto è e rimane
un tabù - come del resto lo è la morte nella nostra società
cristiana occidentale - si è voluta tradurre in uno spettacolo
che slabbra le limitazioni rigide del documentario per far
entrare la narrazione, insolita, del vissuto animale. È
nell’assunzione di questo punto di vista, e più nel dettaglio,
del punto di vista del cane Boston, che si riconosce il valore
di quest’opera che, come raramente può accadere, si può
considerare frutto di originalità.


La Alpi imposta il proprio sguardo all’altezza di animale,
adattando la fotografia con segni evidenti (immagine
traballante e opaca, per esempio) di quell’ipotetica visuale
canina che il Labrador utilizza per indagare il mondo che lo
circonda. Limitata e impossibilitata dunque, e per fortuna, a
osservare il più delle volte il compiersi della brutalità
della soppressione, questa, lascia lo spazio per uno
svolgersi interiore da parte di chi usufruisce del film, e
sviluppa di conseguenza un discorso che procede anche oltre le
immagini. Un cinema calibrato, ponderato, senza bisogno di
eccedere; un cinema nobile. L'autrice non ha alcuna paura a
sottoporre l'essere umano a quella che potrebbe apparire come
una degradazione: umano e animale sono identici, e non ha
importanza come l'uno si serva dell'altro.

La libertà a cui andrà in contro, in un finale malinconico
e intelligentissimo, il cane è l'explicit perfetto per
inferire la dignità che spetta a tutte le creature. Una
dignità fatta di libertà di scelta e di condivisione della
stessa; istintuale, lontano da mistificanti legami, eppur
consapevole che il dolore e il sacrificio non avranno mai
fine.
Maud Alpi ha vinto lo
Swatch Art Peace Hotel Award, di sicuro un premio che
non verrà citato nei giornali ma, si spera, un riconoscimento
che le permetterà di non perdere la fiducia nelle sue qualità
di cineasta. |
|
Alessandro
Tognolo |
|
|
|
 Premiato
come miglior opera prima
del concorso Cineasti del Presente,
El Futuro Perfecto
(futuro anteriore, in italiano) della regista tedesca
trapiantata in Argentina Nele Wohlatz è un film apparentemente
semplice, ma in realtà complesso e che si presta a molteplici
piani di lettura.
Premiato
come miglior opera prima
del concorso Cineasti del Presente,
El Futuro Perfecto
(futuro anteriore, in italiano) della regista tedesca
trapiantata in Argentina Nele Wohlatz è un film apparentemente
semplice, ma in realtà complesso e che si presta a molteplici
piani di lettura.
Arrivata da poco a Buenos Aires, Xiaobin, 17 anni, non parla una
parola di spagnolo, ma anziché isolarsi all'interno del proprio
gruppo etnico (i suoi, gestori di una lavanderia, si rifiutano
di mescolarsi ai locali e di imparare a fondo l'idioma), si
cerca subito un lavoro e mette da parte i primi soldi per
iscriversi a una scuola di lingue. Ed è qui, nel confronto con
altri come lei appartenenti alle più diverse nazionalità, che
comincia il suo cammino all'interno, non solo della lingua
spagnola, ma anche del suo relazionarsi con gli altri e con le
varie situazioni della sua nuova esistenza. Nella scuola conosce
e comincia a frequentare un ragazzo indiano, Vijay; escono,
comunicano quasi a gesti; lui viene da un gruppo etnico se
possibile ancora più chiuso e tradizionalista, e infatti quasi
subito le propone di sposarlo: Xiaobin prende tempo…
Allorché a scuola si arriva allo studio del condizionale e
addirittura del futuro perfecto (quando avrò imparato lo
spagnolo… cosa potrò fare?…), Xiaobin comincia a figurarsi le
varie possibilità che si trova davanti. Cosa succederebbe se
accettasse la proposta del matrimonio indiano (vista sul Taj
Mahal e su splendide spiagge)? E se rompesse con la famiglia si
ridurrebbe forse ad una barbona che fruga nei cassonetti? Le
situazioni sono spesso esilaranti, sia nella scuola ("dovresti
chiamarti Sabrina, assomiglia di più al tuo nome"), sia nel
confronto con la varia umanità delle sue passeggiate bonarensi.




El Futuro Perfecto
è un film sugli incontri-scontri culturali all'interno del mondo
globalizzato, sulle difficoltà dell'integrazione, ma soprattutto
su come il linguaggio interferisca con la vita, su come possa
creare o aiutarci a creare una diversa realtà. Partendo da
esperienze personali, Nele Wohlatz, arrivata adulta in
Argentina, già insegnante di lingue e poi di cinema, ci da una
lezione basica di linguaggio cinematografico. Dalla prima
sequenza della protagonista che risponde a modo suo a un
invisibile interlocutore (curiosità: scena ripresa poi tale e
quale a Torino da un altro film argentino bizzarro ma geniale,
Los Decentes), è tutto un susseguirsi di
campo-controcampo, flashback e flash-forward, dissolvenze e
dissonanze, che dimostrano un dominio assoluto del mezzo.
Divertente, intelligente, giusto premiarlo. Forse la durata
minima di sessantacinque minuti potrebbe rendere difficile una
peraltro meritata distribuzione internazionale. |
|
Giovanni
Martini |
|
|
