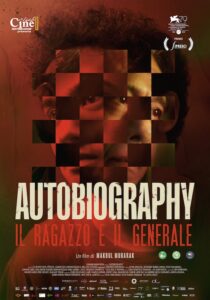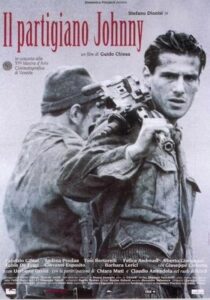Amin, un aspirante sceneggiatore che vive a Parigi, ritorna per l’estate nella sua città natale, una comunità di pescatori nel sud della Francia. È l’occasione per ritrovare la famiglia e gli amici d’infanzia. Accompagnato da suo cugino Tony e dalla sua migliore amica Ophélie, Amin passa il suo tempo tra il ristorante di specialità tunisine dei suoi genitori, i bar del quartiere e la spiaggia frequentata dalle ragazze in vacanza. Incantato dalle numerose figure femminili che lo circondano, Amin resta soggiogato da queste sirene estive, all’opposto del suo dionisiaco cugino che si getta senza remore nell’euforia dei loro corpi. Munito della sua macchina fotografica, e guidato dalla luce eclatante della costa mediterranea, Amin porta avanti la sua ricerca filosofica lanciandosi nella scrittura delle sue sceneggiature.
 Francia/Italia/Tunisia – 3h
Francia/Italia/Tunisia – 3h
 VENEZIA – Il ricordo, qualunque sia la natura che ne domini il significato, scalfisce, con la propria aura pulsionale, le viscere della rappresentazione cinematografica. Il segno distintivo della visione di Abdellatif Kechiche è nascosto nell’intensità di un percorso nel quale è inevitabile perdersi in un infinito susseguirsi contemplativo – una ricerca probabilmente – su di un’inafferrabile estasi della bellezza, allo stesso tempo tragica e inebriante, dalla quale il regista franco tunisino si è elevato oltre la straordinaria ricchezza di uno stile, per farsi genere. Quel genere che in La vita di Adele aveva raggiunto una perfezione formale quasi definitiva, divenendo esso stesso l’espressione di un azzeramento del deficit del cinema nei confronti della percezione del reale, e dunque il trionfo del mezzo dello sguardo rispetto all’albagia di ciò che viene chiamata vita.
VENEZIA – Il ricordo, qualunque sia la natura che ne domini il significato, scalfisce, con la propria aura pulsionale, le viscere della rappresentazione cinematografica. Il segno distintivo della visione di Abdellatif Kechiche è nascosto nell’intensità di un percorso nel quale è inevitabile perdersi in un infinito susseguirsi contemplativo – una ricerca probabilmente – su di un’inafferrabile estasi della bellezza, allo stesso tempo tragica e inebriante, dalla quale il regista franco tunisino si è elevato oltre la straordinaria ricchezza di uno stile, per farsi genere. Quel genere che in La vita di Adele aveva raggiunto una perfezione formale quasi definitiva, divenendo esso stesso l’espressione di un azzeramento del deficit del cinema nei confronti della percezione del reale, e dunque il trionfo del mezzo dello sguardo rispetto all’albagia di ciò che viene chiamata vita.
Intorno ad una fonte, in un pratello
Di verdi erbette pieno e di bei fiori,
Sedeano tre angiolette, i loro amori
Forse narrando; et a ciascuna il bello
Viso adombrava un verde ramoscello
Che i capei d’ôr cingea; al qual di fuori
E dentro insieme i dua vaghi colori
Avvolgeva un soave venticello.
E dopo alquanto l’una alle due disse,
Com’io udii — Deh! se per avventura
Di ciascuna l’amante qui venisse,
Fuggiremmo noi quinci per paura? —
A cui le due risposer — Chi fuggisse,
Poco savia sarìa con tal ventura. —
(Boccaccio, Rime I)
 Il cinema di Kechiche è la vita all’opera, fluisce a partire dalla luce della quale si nutre, e non a caso, alla luce, viene decretato pure un valore teologico, in apertura, con le citazioni dal Vangelo e dal Corano. Da sempre l’essere umano si danna alla ricerca di un senso della propria esistenza, lib(e)rando la fantasia e costruendo fortificazioni: “Mektoub significa destino, kharma, e il film nel suo insieme solleva il significato del destino a cui l’amore (love) si associa sempre. Perché spesso il destino è scritto nei rapporti amorosi”. Nient’altro che questo, fato e amore, in continuo movimento, e dunque tempo. Il tempo in cui niente sembra accadere di così significativo se non il diramarsi della vita, che altro non è se non il susseguirsi di qualcosa che è già stato – il ricordo – e il desiderio di qualcosa che sarà. Il conflitto nasce però dai sensi: il desiderio impera su un dominio unico del senso: là dove lo sguardo brama di posarsi e penetrare, il corpo, con la sua fisicità, la dirompente armonia di forme che si agitano alla ricerca di una esibizionistica soddisfazione fulminea, momentanea ma dilagante e deflagrante, non permette di fermarsi a guardare. Non c’è tempo, dunque. Il conflitto è duplice: del tempo e del desiderio. La macchina da presa di Kechiche è un dispositivo artificiale sottomesso a un controllo emotivo reale. Vivifica in un’attesa che forse racchiude il segreto dell’insistere della vita su questa terra: attesa dell’estasi di un incontro, del perdurare imperituro di un’immagine, di un abbaglio, di una luce in definitiva, del sole, o della luna, o di un giovane sorriso, in grado di far sorgere un’emozione, di impressionare la pellicola di un ricordo, renderlo prospero, infinito, capace di produrre un significato irrintracciabile al vuoto scorrere delle lancette.
Il cinema di Kechiche è la vita all’opera, fluisce a partire dalla luce della quale si nutre, e non a caso, alla luce, viene decretato pure un valore teologico, in apertura, con le citazioni dal Vangelo e dal Corano. Da sempre l’essere umano si danna alla ricerca di un senso della propria esistenza, lib(e)rando la fantasia e costruendo fortificazioni: “Mektoub significa destino, kharma, e il film nel suo insieme solleva il significato del destino a cui l’amore (love) si associa sempre. Perché spesso il destino è scritto nei rapporti amorosi”. Nient’altro che questo, fato e amore, in continuo movimento, e dunque tempo. Il tempo in cui niente sembra accadere di così significativo se non il diramarsi della vita, che altro non è se non il susseguirsi di qualcosa che è già stato – il ricordo – e il desiderio di qualcosa che sarà. Il conflitto nasce però dai sensi: il desiderio impera su un dominio unico del senso: là dove lo sguardo brama di posarsi e penetrare, il corpo, con la sua fisicità, la dirompente armonia di forme che si agitano alla ricerca di una esibizionistica soddisfazione fulminea, momentanea ma dilagante e deflagrante, non permette di fermarsi a guardare. Non c’è tempo, dunque. Il conflitto è duplice: del tempo e del desiderio. La macchina da presa di Kechiche è un dispositivo artificiale sottomesso a un controllo emotivo reale. Vivifica in un’attesa che forse racchiude il segreto dell’insistere della vita su questa terra: attesa dell’estasi di un incontro, del perdurare imperituro di un’immagine, di un abbaglio, di una luce in definitiva, del sole, o della luna, o di un giovane sorriso, in grado di far sorgere un’emozione, di impressionare la pellicola di un ricordo, renderlo prospero, infinito, capace di produrre un significato irrintracciabile al vuoto scorrere delle lancette.
Amin è conteso nel suo desiderare di afferrare una bellezza che riconosce essere là, in quell’istante, il fine ultimo della sua contesa, che  nel suo compiersi diventa unica, impronunciabile, paralizzante, totalizzante. Amin, dannatamente, osserva lo spazio immenso dell’abbandono in quei corpi magnifici delle ragazze che lo circondano, lambendolo, desiderandolo. Il corpo sudato, la pelle abbronzata, il cibo, nella sua tellurica consistenza e nel suo profumo vischioso di spezie e di grasso, il bacio, il sesso, e le parole che scorrono senza possibilità di afferrarle mai del tutto in pieno, tra lacrime, alcool e sorrisi pieni di quel profondo incanto di cui è complice la giovinezza. Se ne percepisce il sussulto del respiro. Kechiche riesce a mettere in scena una metamorfosi: l’immagine travalica la bidimensionalità senza l’ausilio di un ritrovato tecnologico, fonde direttamente la percezione del passivo spettatore con un corpo che ha improvvisamente acquisito un’anima. L’immagine prende fiato, dopo un lunghissimo ballo la platea è affannata, madida, come dopo un amplesso, quasi a dirci che sì, in fondo, danzare e fare l’amore non sono poi così distanti tra loro. Perché è nel corpo che affonda il principio del piacere, il corpo spasima per essere soddisfatto, privo di quel controllo che lo conduce al seppellimento.
nel suo compiersi diventa unica, impronunciabile, paralizzante, totalizzante. Amin, dannatamente, osserva lo spazio immenso dell’abbandono in quei corpi magnifici delle ragazze che lo circondano, lambendolo, desiderandolo. Il corpo sudato, la pelle abbronzata, il cibo, nella sua tellurica consistenza e nel suo profumo vischioso di spezie e di grasso, il bacio, il sesso, e le parole che scorrono senza possibilità di afferrarle mai del tutto in pieno, tra lacrime, alcool e sorrisi pieni di quel profondo incanto di cui è complice la giovinezza. Se ne percepisce il sussulto del respiro. Kechiche riesce a mettere in scena una metamorfosi: l’immagine travalica la bidimensionalità senza l’ausilio di un ritrovato tecnologico, fonde direttamente la percezione del passivo spettatore con un corpo che ha improvvisamente acquisito un’anima. L’immagine prende fiato, dopo un lunghissimo ballo la platea è affannata, madida, come dopo un amplesso, quasi a dirci che sì, in fondo, danzare e fare l’amore non sono poi così distanti tra loro. Perché è nel corpo che affonda il principio del piacere, il corpo spasima per essere soddisfatto, privo di quel controllo che lo conduce al seppellimento.
E così, l’estate del 1994 di Sète, rimanda fatalmente al locus amoenus delle quartine boccacciane, mentre il dialogo delle fanciulle nelle terzine, ci rimanda ad una dimensione molto più concreta, quella di Ophélie, Céline, Charlotte, Camélia: angeli meno eterei che sgretolano sensualmente il desiderio dei loro seduttori, si riappropriano dei loro corpi, delle loro passioni, delle loro malizie, così umane e così simili a quelle dei loro amanti. Contrariamente a ciò che uno sguardo superficiale lascia intendere, Kechiche caratterizza la donna e la sua totale bellezza come soggetto amoroso e non mero oggetto di una momentanea passione. È lo sguardo che desidera, e continuerà a farlo: infatti non c’è fine a questa storia. Solo una pausa. È il primo canto.
Alessandro Tognolo – MCmagazine 43