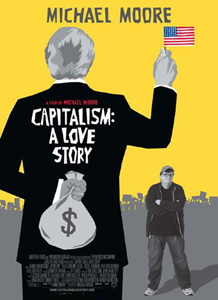|
Se
ci fosse permesso di assistere al meticoloso e caliginoso
funzionamento del sistema limbico probabilmente avremmo una cognizione
visceralmente autentica della reale struttura delle emozioni o
perlomeno degli stati di alterazione verso i quali è soggetto il corpo
umano. La manifestazione esteriore dei sintomi legati all’introiezione
e allo sviluppo di un impulso emozionale il più delle volte appare una
scadente interpretazione di immagini consumate e impersonali di cui
difficilmente si può far tesoro per decifrare intimamente la natura
produttrice di un qualche turbamento. Il cinema è in grado - per
ragioni più e meno evidenti e attraverso modalità che rimarranno, può
darsi, sempre oggetto di indagine - di instaurare una connessione
privilegiata con lo strato selettivo del cervello deputato a
rispondere, in generale, del nostro vincolo affettivo. E quindi, in un
certo senso, la partecipazione all’esperienza della visione mette lo
spettatore in una condizione segretamente critica e ambigua: tanta è
la consapevolezza - da una parte - di essere distaccati, protetti,
testimoni inermi di una rappresentazione, quanta è - dall’altra - la
capacità di penetrazione delle immagini, capaci di spingersi fino a
corrodere la solida e recalcitrante scorza di zelante controllo ed
estenuante attesa di cui si fortificano gli occhi di fronte al gorgo
cinematografico.
 Sul
piano dell’espressione, il cinema, approfittando della forma
documentaristica, e dunque mediante il tangibile riconoscimento
identificatorio operato dalle immagini catturate da un qualsiasi
condiviso e riconosciuto presente, instilla consapevolmente un
dispositivo ritmico di stimolazione sinaptica che induce il nervo
ottico a smascherare quell’inconscio agire proiettivo dell’intera e
globalizzata massa civile di fronte alla concreta esposizione dei
fatti della nostra storia. Ed è quanto sembra aver compreso appieno Sul
piano dell’espressione, il cinema, approfittando della forma
documentaristica, e dunque mediante il tangibile riconoscimento
identificatorio operato dalle immagini catturate da un qualsiasi
condiviso e riconosciuto presente, instilla consapevolmente un
dispositivo ritmico di stimolazione sinaptica che induce il nervo
ottico a smascherare quell’inconscio agire proiettivo dell’intera e
globalizzata massa civile di fronte alla concreta esposizione dei
fatti della nostra storia. Ed è quanto sembra aver compreso appieno
 Michael
Moore, il quale da vent’anni propone con stoica pervicacia la sua
analisi dissacrante sul suo paese, e proprio in onore del ventesimo
anniversario del suo primo film (Roger
& Me), ritorna ad affrontare gli
effetti disastrosi prodotti dal dominio delle grandi aziende sulla
vita quotidiana degli abitanti degli Stati Uniti e del mondo intero.
In
Capitalism: A Love Story
Moore non
modifica lo stile caratterizzante del suo incedere investigativo,
tuttavia attribuisce alla sua incombente figura il ruolo dello
psicopompo, conducendo la nostra attenzione in un doloroso viaggio in
un mondo sfasciato dalle derive egemoniche del denaro, corrotto da un
sistema economico sottilmente e astrusamente devastante, incapace di
comprendere e salvaguardarsi dall’abbandonarsi al sogno del benessere
e dove “il contrasto fra i valori della democrazia e del
capitalismo e la contrapposizione tra l’etica cristiana e il
capitalismo non si possono più ignorare”. La progressione degli
eventi dilaga in un avvicendamento relazionale - e non a caso,
comprendendo tutte le fasi dell’innamoramento e del disgregamento
della storia d’amore - mosso dagli ideali fulgenti di speranze eterne
offerti dal capitalismo, fino a giungere alla scoperta di un
tradimento annunciato e agli esiti personali pagati dalla gente che ha
abbracciato quel sistema economico e sociale. Quella stessa gente che
(soprattutto in America) non conosce e non capisce fino in fondo lo
stato in cui si trova, e la stessa gente a cui si rivolge Moore
esemplificando con estrema chiarezza i passaggi del dramma del
tracollo finanziario globale, e il prezzo altissimo pagato dagli
americani a causa del loro amore per il capitalismo. Michael
Moore, il quale da vent’anni propone con stoica pervicacia la sua
analisi dissacrante sul suo paese, e proprio in onore del ventesimo
anniversario del suo primo film (Roger
& Me), ritorna ad affrontare gli
effetti disastrosi prodotti dal dominio delle grandi aziende sulla
vita quotidiana degli abitanti degli Stati Uniti e del mondo intero.
In
Capitalism: A Love Story
Moore non
modifica lo stile caratterizzante del suo incedere investigativo,
tuttavia attribuisce alla sua incombente figura il ruolo dello
psicopompo, conducendo la nostra attenzione in un doloroso viaggio in
un mondo sfasciato dalle derive egemoniche del denaro, corrotto da un
sistema economico sottilmente e astrusamente devastante, incapace di
comprendere e salvaguardarsi dall’abbandonarsi al sogno del benessere
e dove “il contrasto fra i valori della democrazia e del
capitalismo e la contrapposizione tra l’etica cristiana e il
capitalismo non si possono più ignorare”. La progressione degli
eventi dilaga in un avvicendamento relazionale - e non a caso,
comprendendo tutte le fasi dell’innamoramento e del disgregamento
della storia d’amore - mosso dagli ideali fulgenti di speranze eterne
offerti dal capitalismo, fino a giungere alla scoperta di un
tradimento annunciato e agli esiti personali pagati dalla gente che ha
abbracciato quel sistema economico e sociale. Quella stessa gente che
(soprattutto in America) non conosce e non capisce fino in fondo lo
stato in cui si trova, e la stessa gente a cui si rivolge Moore
esemplificando con estrema chiarezza i passaggi del dramma del
tracollo finanziario globale, e il prezzo altissimo pagato dagli
americani a causa del loro amore per il capitalismo.
Ebbene, se il percorso nel tartaro in cui è sprofondato l’opulento
mondo consumato dal predominio delle banche e dei grandi gruppi
finanziari sembra essere destinato a proseguire inesorabilmente verso
l’obsolescenza, con questo film si innesca, in un montare silente
quanto irreprimibile, uno sfogo emotivo e l’impulso radicale
all’insurrezione, democratica e culturale, invocata da Moore come
unica possibilità di redenzione. In questo modo il regista di Flint
infrange quel vincolo consolidato del cinema con il pubblico e
permette il dispiegamento diretto degli effetti erotti dalle sue
immagini. Invita tutti a rendersi conto di quale perturbamento può
portare decidere di vedere, e constatare l’assenza di un qualsiasi
banale scarto tra cinema e vita. Invita ad adoperare invece quelle
armi di cui può essere munito ogni spettatore intorpidito, e dunque
abdicare la sacralità del ruolo testimoniale per assumere quello del
protagonista.
Poiché ci è concesso solamente osservare l’esito prodotto da un
qualche effetto, restare indifferenti all’appello significa - con
un’ipotesi tutt’altro che avanguardistica - constatare la presenza di
una carenza, un’occlusione (ideologica?), una sospensione
dell’attività dei neuromediatori del circuito limbico. Partecipare
allo sviluppo funzionale di aspetti tali per importanza da permettere
un cambiamento della realtà è plausibilmente il carattere
effettivamente eversivo di
Capitalism: A Love Story.
Ed è per questo che Michael Moore non rinuncerà mai al suo ibrido
guardare, e resterà ancora una necessaria e invitante fonte di
discussione e controversie.
|
![]() Venezia 66° - Concorso
Venezia 66° - Concorso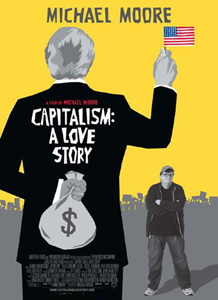
![]() Venezia 66° - Concorso
Venezia 66° - Concorso