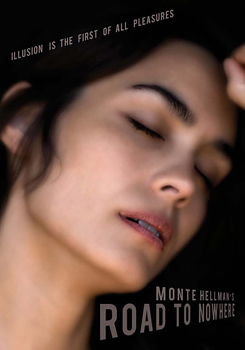|
Il
cinema attraversa, riproduce, rielabora e proietta l’apparato psichico
umano, i suoi meccanismi pulsionali e i suoi princìpi regolatori. Fin
dal principio l’illusione e il sogno, il desiderio e lo scontro e la
verifica con la realtà - intesa come funzione delle condizioni imposte
dal mondo esterno - si sono dimostrate consequenziali strutture
semantiche per raccontare e scollare l’effetto perturbante prodotto
dalla visione dello schermo cinematografico. Può anche capitare però,
che gli stessi elementi identificanti dell’oggetto e del dispositivo
fantasmatico, e dunque gli assi portanti di una valida ipotesi
interpretativa, divengano soggetti e, a loro modo, protagonisti della
riflessione e rappresentazione filmica. Di conseguenza, l’autore si
svela come una presenza fondamentale ed evidente, necessariamente
portata ad affermare quel suo punto di vista riflettente e plurivoco,
intensamente metacinematografico, ma non per questo disincantato,
determinato dalla basilare e incontrovertibile dicotomia delle istanze
di piacere e realtà.
Il noir tra tutti è forse il genere che meglio incarna l’enigma del
desiderio, e che meglio si presta a racchiudere la complessità delle
derive associate ad esso, come l’ossessione, il possesso, la colpa, la
perdita, l’inganno, la ripetizione, in un costante intreccio di
scenari e piani narrativi scardinati dal mero procedimento logico
dello sviluppo narratologico classico. E in tal senso la monistica
avanguardia dell’INLAND
EMPIRE lynchiano resta tuttora un riferimento determinante
per approcciarsi ad uno sguardo formale esaltante, benché misterioso e
inquietante, sull’intreccio prolifico dell’immaginario con l’apparente
consapevolezza della vita.
Osservando questo territorio ardimentoso e scosceso, Monte Hellman,
uomo indissolubilmente legato alla materia cinematografica,
indipendente per natura (si è formato nella factory di Roger Corman),
regista - suoi alcuni dei western chiave della svolta antiretorica del
genere:
Le colline blu
(1966), La sparatoria
(1966); e il road movie
esistenziale Strada a doppia corsia
(1971) - montaggista per Sam
Peckinpah (Killer Elite), Bob Rafelson (Sogni perduti - Head), Jonathan Demme (Fighting Mad) e produttore dell’esordio di Quentin
Tarantino (Le
iene), si presenta a settantotto anni con il suo film
più personale, labirintico, teso, fervido concentrato d’amore per le
immagini e la loro esecuzione.
Road to Nowhere prospetta fin dal
titolo un percorso incerto, quello del desiderio verso la conquista
della sua letale inafferrabilità, e racchiude concettualmente tutto il
pensiero di un autore sul destino e il fine ultimo dell'idea con la
quale potrà sopravvivere il mezzo cardinale deputato alla creazione
dei sogni.
Il film racconta del giovane regista Mitchell Haven e della
sua ossessione per la realizzazione del suo nuovo capolavoro, un
torbido giallo dal tragico finale, tratto da una storia vera, e con al
centro una bellissima ragazza e il suo vecchio e potente compagno.
Mitchell è innamorato di questa storia e della sua protagonista, Velma
Duran. Il suo amore diventa tutt’uno con la sua vita nel momento in
cui ingaggia la splendida modella e attrice Laurel Graham per
interpretare Velma, con la quale vanta un’incredibile somiglianza, e
inizia a girare proprio nello stesso luogo dei reali avvenimenti del
suo complicato mistero.
Road to Nowhere opera uno smembramento del codice di genere,
affermando il dominio della purezza di una forma in costante
mutamento, volutamente costruita, e percepita come tale, nel suo
processo costitutivo. Dunque ci si chiede quale film, e quale trama,
stia realmente seguendo lo spettatore, poiché dopo qualche sequenza
l’interrogativo diviene l’unica coerente strada percorribile. In
questo gioco delle possibili letture però, appare sempre più evidente
uno schema non casuale, e abilmente regolato dallo sguardo del suo
creatore, in cui tutto è doppio e intercambiabile: Monte
Hellman-Mitchell Haven, Velma Duran-Laurel Graham, la storia vera di
Velma-il film che si sta girando su quella storia-la storia vera di
Laurel. In sostanza si tratta dell’amore sviscerato per l’immortalità
del magnifico tormento per l’immagine, e la sua necessaria forza
vivifica. E il ritratto con il quale si conclude il film, contemplato
da Mitchell, esemplifica appunto l’estasi di questo assunto. Il potere
attrattivo della visione, e l’ossessivo immergersi e perdersi dentro
ad essa, rappresentano di fatto la base dalla quale si dipanano le
possibili narrazioni di
Road to Nowhere. Ma, sebbene con un certo
sforzo programmatico sia possibile rilevare i fulcri di questo
perfetto meccanismo di compenetrazione di differenti piani del
racconto, si dimostra evidente che, in sostanza, proprio il nostro
stesso guardare e interrogarci su cosa stiamo fissando, chiarisca quel
senso sfuggente del quale abbiamo bisogno per decifrare l’esito della
portata figurativa dell’opera di Hellman. Il suo cinema ha il sapore
persistente del mistero, il coraggio dell’introspezione e la
consistenza dell’avventura: “Road to Nowhere è una collaborazione
dell’intero gruppo creativo che è stato invitato ad attingere al suo
subconscio. Non sapevamo dove ci avrebbe condotto questa strada, e
solo adesso consideriamo il film una celebrazione del potere
esercitato dal cinema sulla nostra immaginazione, come pure una
verifica dell’elasticità della nostra sospensione volontaria
dell’incredulità”. e interrogarci su cosa stiamo fissando, chiarisca quel
senso sfuggente del quale abbiamo bisogno per decifrare l’esito della
portata figurativa dell’opera di Hellman. Il suo cinema ha il sapore
persistente del mistero, il coraggio dell’introspezione e la
consistenza dell’avventura: “Road to Nowhere è una collaborazione
dell’intero gruppo creativo che è stato invitato ad attingere al suo
subconscio. Non sapevamo dove ci avrebbe condotto questa strada, e
solo adesso consideriamo il film una celebrazione del potere
esercitato dal cinema sulla nostra immaginazione, come pure una
verifica dell’elasticità della nostra sospensione volontaria
dell’incredulità”.
Guardare, nel suo formasi e corrompersi, la finzione, e prendere
coscienza di quanto essa non sia differente da ciò che crediamo essere
reale. Un tema certo non nuovo, ma che nella mani di Hellman diviene
un declinarsi nitido, erotico, perfetto di immagini portatrici di un
suggestivo valore purificatorio. Del resto, cosa si può ancora
inventare e dire di autenticamente nuovo. La differenza sta, come
sempre, nella scelta della forma che si determina di utilizzare. E
Road to Nowhere è proprio la sintesi del fascino indissolubile
esercitato dalla forma verso la sua significazione.
|