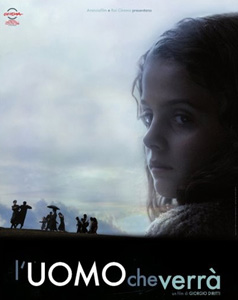|
Succede
ancora. Ogni tanto un regista allergico alle convenzioni soffia via la
polvere da pagine che credevamo di sapere a memoria. Quanti film abbiamo
visto sugli orrori nazisti? Quante stragi, quanti rastrellamenti, quanti
tedeschi urlanti in armi? L'uomo che verrà di Giorgio Diritti è il
contrario di tutto questo. Non la ricostruzione di una pagina di Storia,
con tutte le maiuscole e il kitsch del caso, ma il prodursi di un evento
che sembra accadere sotto i nostri occhi per la prima volta.
È ciò che il cinema cerca di fare quasi sempre, non riuscendoci quasi mai.
Eppure non c'è trucco. Basta spogliarsi di tutto ciò che sappiamo - oggi -
su quell'evento. Per viverlo con gli occhi di chi lo visse, allora, come
un fatto enorme e incomprensibile perché del tutto estraneo al proprio
sapere e alla propria scala di valori. Facile a dirsi, meno a farsi.
Diritt i ,
già regista di
Il vento fa il suo giro,
ci riesce sposando dall'inizio alla fine lo sguardo dei contadini di Monte
Sole, secondo logiche e ritmi che non appartengono alla Storia e alle sue
guerre ma alla cultura contadina, al rapporto con la natura, a quella
concezione arcaica e sacrale della vita già cara, con accenti diversi, a
Olmi e Pasolini. ,
già regista di
Il vento fa il suo giro,
ci riesce sposando dall'inizio alla fine lo sguardo dei contadini di Monte
Sole, secondo logiche e ritmi che non appartengono alla Storia e alle sue
guerre ma alla cultura contadina, al rapporto con la natura, a quella
concezione arcaica e sacrale della vita già cara, con accenti diversi, a
Olmi e Pasolini.
In mani meno abili poteva diventare retorico. In quelle di Diritti e dei
suoi eccellenti interpreti, scelti mescolando non professionisti ad attori
veri come Alba Rohrwacher, Maya Sansa o Claudio Casadio, interprete di
teatro per ragazzi qui al suo primo film, diventa un esercizio di
straniamento poetico che ripaga lo spettatore con un'emozione e una
comprensione delle cose straordinarie. Una madre incinta (Sansa); una zia
che torna dalla città, l'unica che sa leggere e scrivere (Rohrwacher); una
bambina che non parla più per un trauma (la commovente Greta Zuccheri
Montanari) ma vede e capisce tutto di tedeschi, ribelli e alleati, tanto
da scrivere un tema così compromettente che la maestra glielo brucia. Poi
i racconti la sera, tutti insieme, adulti e bambini, si parli di
emigrazione o del partigiano che ha ucciso un fascista. In dialetto
naturalmente, una lingua sonora e pietrosa oggi quasi estinta che dà peso
e rilievo a ogni parola (l'italiano lo parlano solo i tedeschi, il padrone
o un funzionario comunale in città).
Così fra il dicembre '43 e il settembre '44 prende vita un microcosmo
pulsante di affetti, dubbi, speranze, paure, che prima di esser spazzati
via dall'eccidio, messo in scena con aspro pudore e dettagli rivelatori
(quel prete che si unisce ai balletti nazisti per evitare che la festa
degeneri in orgia, e finisce ucciso), acquistano un'innocenza, una
densità, una verità, scomparse nel cinema d'oggi. Un capolavoro, limpido e
accessibile, di cui essere orgogliosi. Chiedendosi anche perché ci siano
voluti tanti anni per avere un film così libero e rigoroso sul tema.
|
|
Inondati
da rievocazioni scolastiche o ricostruzioni troppo schematiche della
Seconda guerra mondiale e dei suoi episodi, dove il cinema viene piegato
alle ambizioni propagandistiche di questo o di quello, la visione di
L'uomo che verrà
offre lo stesso sollievo di una boccata di aria fresca a chi si sente
soffocare. Rigoroso, emozionante, onesto, appassionato, il film di Diritti
sa coniugare lucidità morale e lettura storica con uno stile insolito per
il cinema italiano, di elegante e non ostentata classicità. Da vero (e
grande) regista. A l Festival di Roma aveva vinto il Gran premio della
Giuria e quello del Pubblico (con qualche scorno per chi non l'aveva
selezionato a Venezia) e oggi inaugura - speriamo beneaugurante - la
distribuzione della rinnovata Mikado, passata di mano (da DeAgostini a
Tatò) nell'autunno scorso. Il film, ambientato nelle colline bolognesi
vicino a Marzabotto, racconta la dura vita quotidiana della famiglia
contadina Palmieri, dall'inverno 1943 all'autunno 1944: i nazisti
presidiano con determinazione la Linea gotica, i partigiani si impegnano
nell'infastidire e sabotare le azioni degli occupanti e i civili cercano
di campare alla meno peggio, subendo le intimidazioni degli uni e le
richieste degli altri, mentre la vita non può che continuare il suo
percorso: Lena (Sansa) porta in grembo l'«uomo che verrà» a cui fa
riferimento il titolo, la cognata Beniamina (Rohrwacher) spera di
migliorare la sua condizione andando a servire a Bologna, il marito
Armando (Casadio) si dibatte tra i vincoli della mezzadria e le
imposizione fasciste, tutti, insieme ai contadini che abitano nella stessa
cascina, condividendo la dura vita quotidiana e quel che resta della
voglia di trovarsi insieme a ballare o chiacchierare. A guidare lo
spettatore c'è lo sguardo curioso di Martina (Zuccheri Montanari), la
figlia di Lena e Armando, diventata muta dopo la morte di un precedente
fratellino e trepidante custode di quello in arrivo: grazie a lei
conosciamo i comportamenti delle truppe naziste, le fughe precipitose nei
nascondigli tra i boschi, le azioni dei partigiani, le morti e le
sconfitte, ma soprattutto l'inevitabile intrusione della guerra, e della
sua violenza, nella vita di tutti i giorni. Il fratellino nascerà nella
notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 e la Storia ci ha già detto che
cosa succederà negli stessi giorni: in nome di un'agghiacciante esigenza
di «bonifica territoriale», i nazisti rastrellano più di ottocento
persone, soprattutto donne, bambini e anziani, che uccidono senza nemmeno
la giustificazione di una rappresaglia. Non anticipiamo il destino dei
personaggi che abbiamo conosciuto e che il film mostra con documentata
partecipazione ma sarebbe ingiusto ridurre
L'uomo che verrà
a una, pur corretta, ricostruzione della strage di Monte Sole (Marzabotto
è solo uno dei comuni della zona, quello più conosciuto). Diritti guarda
oltre, alla sofferenza e alla disperazione di tutti coloro che il cinismo
del linguaggio definisce come «danni collaterali», al dolore e alla
tragedia di quegli inermi che pagano sulla propria pelle la follia della
guerra. Per farlo non amplifica le occasioni di spettacolo o di suspense.
Non gli interessa - giustamente - farci palpitare per chi si salva perché
dietro a ogni vita risparmiata ce ne sono troppe distrutte. Piuttosto
vuole farci riflettere sulle assurdità delle guerre e delle violenze. E
non tanto in nome di un pacifismo razionale ma per un'umanissima empatia
con le vittime. A quegli uomini, quelle donne e quei bambini che vanno
incontro alla morte ci siamo affezionati vedendo la grama vita quotidiana,
sentendo il loro odore di terra o di stalla e soffrendo la loro stessa
povertà, ascoltando la durezza di una lingua che ha le stesse asprezze dei
volti (per questo era necessario far parlare tutti in dialetto; per questo
non disturbano i necessari sottotitoli). Diritti filma tutto con uno stile
che sarebbe piaciuto a Bazin e a chi come lui rivendicava al cinema la
capacità di restituire sullo schermo la forza della realtà: gira dal vero,
mescola volti di professionisti (Sansa, Rohrwacher, Casadio: tutti
eccellenti) a altri presi sul posto (la piccola Greta Zuccheri Montanari
ma anche i tanti vecchi dei luoghi, alcuni, da giovani, testimoni del vero
eccidio nazista), evita luoghi comuni e cadute retoriche. E riesce a
regalarci una delle più belle prove di un cinema finalmente necessario, di
altissimo rigore morale e insieme di appassionante e coinvolgente forza
civile. Un capolavoro. |