|
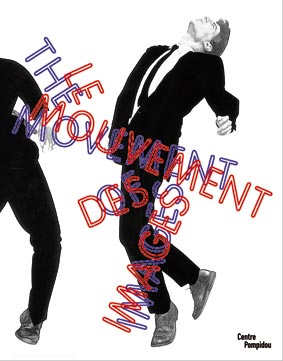 Non
appare casuale che proprio in Francia, paese che per primo ha visto
manifestarsi una riflessione sul cinema e sul suo linguaggio che ne ha
favorito la collocazione in una dimensione diversa da quella di semplice
intrattenimento per le masse, sia stata realizzata una bellissima mostra
curata da Philippe Alain Michaud che affronta il problema del rapporto tra
il cinema e le altre arti, attraverso una rilettura dell’arte del XX
secolo e contemporanea dal punto di vista del cinema. Una mostra
notevole non solo per la preziosità del materiale esposto, ma soprattutto
per il lavoro di ricerca che ha supportato l’esposizione delle opere, ben
documentato dal ricco catalogo.
Non
appare casuale che proprio in Francia, paese che per primo ha visto
manifestarsi una riflessione sul cinema e sul suo linguaggio che ne ha
favorito la collocazione in una dimensione diversa da quella di semplice
intrattenimento per le masse, sia stata realizzata una bellissima mostra
curata da Philippe Alain Michaud che affronta il problema del rapporto tra
il cinema e le altre arti, attraverso una rilettura dell’arte del XX
secolo e contemporanea dal punto di vista del cinema. Una mostra
notevole non solo per la preziosità del materiale esposto, ma soprattutto
per il lavoro di ricerca che ha supportato l’esposizione delle opere, ben
documentato dal ricco catalogo.
L’assunto da cui i curatori sembrano essersi mossi
potrebbe essere sintetizzato dall’affermazione di W. Benjamin secondo cui
“è meno importante sapere se la fotografia e il cinema hanno a che fare
con l’arte, che capire come essi modifichino la percezione che noi abbiamo
di essa” (W. Benjamin - L’opera d’arte nell’epoca della sua
riproducibilità).
Oggi, alle soglie del XXI secolo, stiamo infatti
assistendo ad una massiccia migrazione delle immagini in movimento dalle
sale cinematografiche agli spazi di esposizione, migrazione nata con la
rivoluzione digitale e preparata da un doppio fenomeno: di
dematerializzazione delle opere da un lato e di un ritorno alla teatralità
della scena artistica dall’altro. Diventa pertanto possibile, per non dire
necessario, ridefinire il cinema, al di fuori di quelle categorie entro
cui è stato collocato per tutto il XX secolo. Le immagini in movimento
hanno prodotto dei nuovi regimi di percezione e intelligibilità che si
riflettono su tutte le arti cosiddette “statiche”, pittura, scultura,
fotografia, ma anche architettura e design.
La mostra si propone, con efficacia, di dimostrare come il cinema, dopo
aver “nutrito” le problematiche dell’arte del XX secolo, stia tuttora
condizionando quelle del secolo entrante.
L’esposizione risulta divisa in due parti. La
prima offre una stimolante panoramica di
film concepiti non come
narrazione, ma come sperimentazione linguistica:
dagli esperimenti dada-surrealisti alla video-arte contemporanea, con
lavori di Nam June Paik, Robert Longo, Peter Fischli
e David Weiss, Marc Lewis, Chris Burden, Matthias
Muller (per citare i più noti). Tutte opere concepite per essere
proiettate non in una sala cinematografica, ma in spazi di esposizione, su
schermi, pareti, soffitti, pavimenti; opere che hanno quindi modificato la
nostra modalità di visione, da quella statica all’interno di una sala buia
per la durata prestabilita del film in una rievocativa semmai delle
passeggiate davanti ai “panorama” dei tempi del pre-cinema.
|
   |
|
Robert Longo
Men in the Cities
(Triptych Drawings for the Pompidou)
1980-1999 |
La seconda parte è divisa a sua volta in sezioni, i
cui titoli significativi (défilement – projection – rècit – montage)
indicano il percorso di indagine seguito su come i concetti di
destrutturazione e di movimento,
che stanno alla base del cinema, siano da considerarsi
quali
principali fattori di ricerca di una nuova concezione dell’arte.
Si possono così ammirare gli esperimenti degli artisti che, negli anni
’60-’70, nel sottolineare la materialità fisica del film e nel dissociare
i suoi elementi (proiettore – macchina da presa – luce – schermo) hanno
messo in evidenza i limiti del mezzo come erano stati definiti nel corso
di un secolo.
Utilizzando un proiettore modificato, a cui ha tolto l’otturatore, Paul
Sharits produce un flusso di colori senza definizioni né contorni. I
film dipinti direttamente sulla pellicola di Stan Brakhage
trasformano l’evento della proiezione in una rivelazione del trattamento
plastico della superficie.
Nell’opera di Anthony McCall Linea che descrive un cono dei
coni di luce vengono proiettati senza schermo in un ambiente fumoso che
trasforma i raggi luminosi in forme scultoree nel momento in cui gli
spettatori entrano nel cono di luce.
Zen for film di Nam June Paik del ’64 è la proiezione di un
fotogramma non impressionato su una parete bianca sulla quale lo
spettatore può contemplare la polvere che gradualmente si accumula, i
graffi che si creano sulla pellicola: sabbia di un giardino zen messo in
verticale...
|
 |
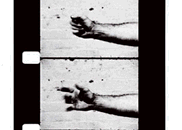 |
|
Fernand Léger
Le Ballet mécanique
1923-1924 |
Richard Serra
Hand Catching Lead
1939 |
Così come nel
cinema la proiezione in successione dei fotogrammi (24 al secondo) produce
l’illusione della continuità, la partitura regolare delle superfici di
Josef Albers e Barnett Newman o l’adozione di formati
longitudinali di Donald Judd permettono di mettere in movimento o
di dinamizzare le superfici, di produrre fenomeni di sviluppo discontinuo
che richiamano all’esperienza cinematografica indipendentemente
dall’apparato tecnico del cinema. La ripetizione seriale di una forma (Warhol)
cambia la forma stessa in movimento, collocandola in una dimensione non
più statica, ma dinamica, introducendo quindi anche il concetto di durata
temporale.
|
 |
|
Andy Warhol
Ten Lizes
1963 |
D’altra parte in tutta l’arte contemporanea l’opera
non è più concepita come un oggetto chiaramente delimitato, ma piuttosto
come uno sviluppo continuo che richiede uno spazio circostante e che allo
stesso tempo fa appello al parametro del tempo.
Per Ejzenstejn il montaggio comincia all’interno del fotogramma. Il
rapporto tra piani e tra sequenze è un’espansione del lavoro
dell’inquadratura. Il cinema nel suo insieme non è che il culmine di
queste procedure di assemblaggio che attraversano la storia dell’arte come
quella della letteratura e di cui Ejzenstejn ritrovava le tracce nei
volumi architettonici del Partenone, nei paesaggi di Toledo dipinti dal
Greco o nelle scene di battaglie descritte da Puskin.
Il taglio delle superfici dipinte, i contrasti dimensionali degli oggetti
dipinti, i giochi sulla trasparenza e l’opacità e la sovrapposizione dei
piani, tutti possono essere interpretati alla luce del dispositivo filmico
come effetti di montaggio: i collage cubisti, costruttivisti e
surrealisti, gli assemblaggi pop o postmoderni creano una molteplicità di
immagini o di frammenti di immagini in una sequenza unica, mostrando in
simultaneità ciò che il cinema mette in successione e producendo così un
equivalente statico della dinamicità e della sequenzialità dei fotogrammi.
Nonostante lo spettro limitato della sua storia, il cinema viene
interpretato per la prima volta come un modo per ripensare le immagini,
non più a partire dai concetti di unicità e immobilità, secondo il modello
Winkelmanniano, che per tutto il XX secolo ha condizionato l’esibizione
delle opere, ma sulla base delle nozioni di mobilità e molteplicità : la
mostra va così a coprire un vuoto teorico di fatto esistente, stimolando,
mi auguro, un nuovo filone di ricerca.
Cristina Menegolli
|