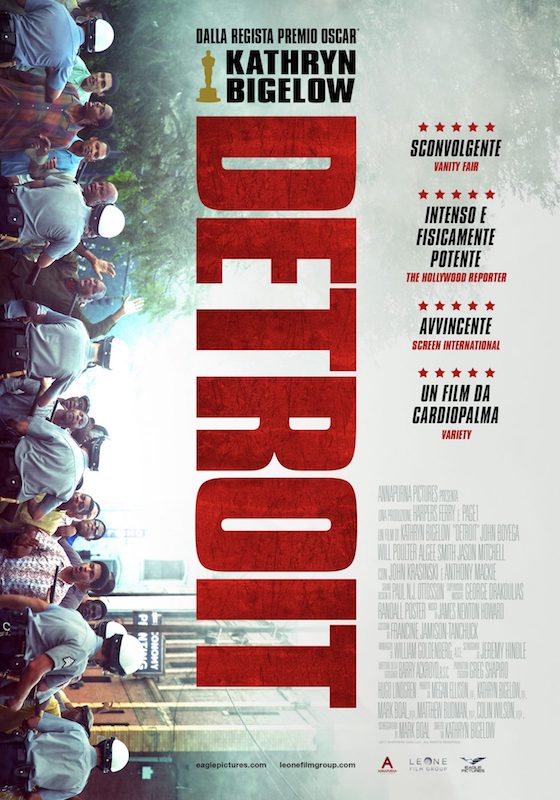La storia è ispirata alle sanguinose rivolte che sconvolsero Detroit nel 1967. Tra le strade della città si consumò un vero e proprio massacro ad opera della polizia, in cui persero la vita tre afroamericani e centinaia di persone restarono gravemente ferite. La rivolta successiva portò a disordini senza precedenti, costringendo così a una presa di coscienza su quanto accaduto durante quell’ignobile giorno di cinquant’anni fa. Ancora una volta la Bigelow dimostra una magistrale capacità di sintesi narrativa e di ritmata spettacolarità, la sua è una regia muscolare e adrenalinica che stordisce ma di cui il cinema d’oggi ha bisogno.
USA 2017 – 2h 22′
Nel 1967, in piena epoca di battaglie per i diritti civili da parte degli afroamericani (Martin Luther King sarebbe stato ucciso nel ’68 sul balcone del Lorraine Motel di Memphis), nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar dove si vendevano alcolici senza permesso. Il governatore del Michigan inviò la Guardia Nazionale a sedare la rivolta, e il presidente Lyndon Johnson gli fece dare man forte dall’esercito. L’episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppetto di giovani uomini neri e di due ragazze bianche all’interno del Motel Algiers: un episodio di brutalità da parte della polizia (con il fiancheggiamento di alcuni militari) che è una ferita nella coscienza dell’America.
 Negli Stati Uniti il massacro del Motel Algiers è molto noto, lo è invece molto meno nel resto del mondo. E la scelta di Kathryn Bigelow di concentrare la propria attenzione su quell’evento accaduto cinquant’anni fa è parte della generale riflessione che il cinema americano sta facendo sulla “questione afroamericana”.
Negli Stati Uniti il massacro del Motel Algiers è molto noto, lo è invece molto meno nel resto del mondo. E la scelta di Kathryn Bigelow di concentrare la propria attenzione su quell’evento accaduto cinquant’anni fa è parte della generale riflessione che il cinema americano sta facendo sulla “questione afroamericana”.
Bigelow, come sempre, si muove in piena autonomia espressiva, e sono davvero pochi i registi con la sua capacità di creare una messa in scena ampiamente spettacolare e profondamente coinvolgente. Ma la messa in scena non è tutto, specialmente quando si tocca un nervo scoperto nella coscienza di una nazione. Con la sua camera a mano, nervosa e inquieta come il momento storico che racconta, con quella regia muscolare concentrata sull’azione più che sull’introspezione la regista ci ficca in mezzo al clima elettrico dell’epoca, e poi ci chiude tutti in quel motel senza poterci sottrarre a ciò che sta per accadere, come non hanno potuto farlo i diretti interessati. Ciò che succederà è un’escalation di violenza, intimidazione e umiliazione dell’uomo (bianco) sull’uomo (nero) che si protrae per ben 40 dei 143 minuti di durata del film.
 Il problema nasce proprio all’interno di quei 40 minuti di puro cinema, perché è lì che la storia che Bigelow racconta, che
Il problema nasce proprio all’interno di quei 40 minuti di puro cinema, perché è lì che la storia che Bigelow racconta, che
doveva essere paradigmatica della questione afroamericana, perde la sua specificità e rischia di trasformarsi in Un tranquillo weekend di paura: l’ottusa perfidia dei tre poliziotti bianchi che tengono in ostaggio il gruppetto eterogeneo di uomini neri (fra cui un veterano del Vietnam e un cantante in stile Motown) si scollega a poco a poco dalla motivazione specificatamente razziale e diventa una vetrina dell’umana aberrazione, protratta così a lungo e così cinematograficamente insistita che qualche critico oltreoceano l’ha definita “torture porn”, cioè compiacimento pornografico sulla tortura. Prima ancora che una questione morale, questa insistenza mette in gioco la compattezza narrativa di Detroit perché scollega l’azione dal contesto, e fa apparire la discriminazione contro gli afroamericani e la brutalità della polizia bianca nei confronti della comunità nera meno sistemica di quanto non fosse e ancora oggi sia – e come tale debba essere rappresentata.
Paola Casella – mymovies.it
 Kathryn Bigelow con Detroit decide di raccontare uno degli episodi più importanti di quel grande decennio di politicizzazione black che sono stati gli anni Sessanta… Nonostante un breve prologo di contesto – per altro pieno di inesattezze – decide invece di dare una forma alla sua rappresentazione di segno opposto, tutta giocata sull’incertezza e la contingenza dell’evento visto dall’interno. Il film inizia con una retata della polizia nella festa di un locale semiclandestino popolato da soli neri, che contravvenendo alla proibizione della vendita di alcolici viene chiuso in fretta e furia. L’arresto di massa che ne consegue finisce, quasi per caso, per provocare la reazione violenta dei presenti che si intensifica fino a diventare un vero e proprio riot e poi una sommossa generalizzata a tutta la città. Tuttavia è soprattutto la forma dell’immagine a colpire: un’instabile e frenetica camera a mano piena di movimenti irregolari, e un insieme confuso di molte voci a volte difficili da isolare l’una dall’altra.
Kathryn Bigelow con Detroit decide di raccontare uno degli episodi più importanti di quel grande decennio di politicizzazione black che sono stati gli anni Sessanta… Nonostante un breve prologo di contesto – per altro pieno di inesattezze – decide invece di dare una forma alla sua rappresentazione di segno opposto, tutta giocata sull’incertezza e la contingenza dell’evento visto dall’interno. Il film inizia con una retata della polizia nella festa di un locale semiclandestino popolato da soli neri, che contravvenendo alla proibizione della vendita di alcolici viene chiuso in fretta e furia. L’arresto di massa che ne consegue finisce, quasi per caso, per provocare la reazione violenta dei presenti che si intensifica fino a diventare un vero e proprio riot e poi una sommossa generalizzata a tutta la città. Tuttavia è soprattutto la forma dell’immagine a colpire: un’instabile e frenetica camera a mano piena di movimenti irregolari, e un insieme confuso di molte voci a volte difficili da isolare l’una dall’altra.
 In Detroit insomma regna un sentimento di caos e disorientamento. Ma è soprattutto il fraintendimento a farla da padrone, dato che è da un insieme di leggerezze, pressapochismo e ignoranza dei confini giuridici del proprio ruolo che nasce uno dei primi omicidi a opera di un giovane poliziotto impulsivo, così come è da una pistola giocattolo che viene sparata contro la Guardia Civile dalla finestra di una pensione, l’Algiers Motel, che prende corpo quella che è a tutti gli effetti la scena madre del film.
In Detroit insomma regna un sentimento di caos e disorientamento. Ma è soprattutto il fraintendimento a farla da padrone, dato che è da un insieme di leggerezze, pressapochismo e ignoranza dei confini giuridici del proprio ruolo che nasce uno dei primi omicidi a opera di un giovane poliziotto impulsivo, così come è da una pistola giocattolo che viene sparata contro la Guardia Civile dalla finestra di una pensione, l’Algiers Motel, che prende corpo quella che è a tutti gli effetti la scena madre del film.
Detroit si sviluppa infatti lungo tre atti, ma è l’atto centrale quello attorno a cui ruota il film (dura quasi un’ora). “Credendo” che gli stiano sparando addosso da una stanza d’albergo un gruppo di militari e poliziotti entra per compiere una retata in una pensione dove si sta tenendo una piccola festa (da un gruppo di neri e da due ragazze bianche che si trovano per caso e per la prima volta insieme). Tuttavia è proprio in conseguenza del fatto che l’arma che viene ricercata non esista, che si assiste a un’escalation di violenza e sadismo sempre più estrema.
Pietro Bianchi – cineforum.it